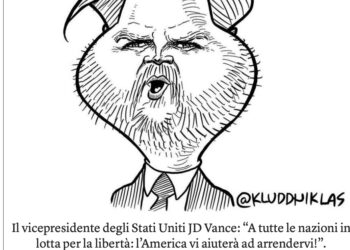Le bugie sono state sdoganate, specie Oltreoceano, ma in Italia non ce le facciamo mancare, anzi, se la materia sensibile è il fisco. Giorgia Meloni si svena per convincere gli italiani di avere abbassato le tasse e s’indigna pure quando l’opposizione le contesta la narrazione. Analisi, esperti, economisti spiegano come stanno le cose, dandole torto marcio, ma lei non fa marcia indietro, non arretra di un passo. L’ultimo expertise arriva da due investigatori che godono grande esperienza e stima unanime, Milena Gabanelli e Andrea Priante, che sul Corriere della Sera hanno disegnato la realtà: la pressione fiscale è cresciuta ancora con il governo di centrodestra, giungendo al 42,8 per cento. Ed ancora una volta tocca ai sindaci fare “il lavoro sporco”: alzare IRPEF, TARI E IMU per 4 miliardi. Uno scarica barile che ha un risvolto politico. Gli amministratori locali sono il frangiflutti delle istanze popolari; sono lo Stato senza avere alcuna voce in capitolo sulle scelte compiute a livello centrale.
La storia è vecchia, ce la ricorda il Corriere: “Silvio Berlusconi lo ha ripetuto fino allo sfinimento «non ho mai messo le mani nelle tasche degli italiani»; Matteo Renzi si è vantato di «un impegno di riduzione delle tasse che non ha paragoni nella storia repubblicana di questo Paese»; Giuseppe Conte aveva annunciato «il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi»; anche la premier Giorgia Meloni, nell’illustrare l’ultima manovra finanziaria, ha rivendicato che «come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini». Se torniamo indietro negli anni vediamo che nel 2023 la pressione fiscale era del 40%, da allora ci sono state minime ma continue oscillazioni con un picco oltre il 43% con i governi Letta-Renzi: oggi siamo al 42,8% (fonte Ocse).
Tradizionalmente negli enti locali prevalgono sindaci di centrosinistra o civici, le loro “cattive azioni” in materia fiscale, dunque, lasciano fuori le responsabilità centrali. Quando un comune deve colmare un divario insopportabile fra servizi pubblici e bisogni dei cittadini, mettere mano alle tasse locali è l’unica alternativa. Coperta corta, a pagare è la periferia, cioè i comuni; in specie quelli che accusano il deficit più alto di bisogni inevasi. Lo scaricabarile funziona magnificamente da sempre, tanto da mettere a riparo i governanti nazionali e le loro menzogne.
Come scrivono la Gabanelli e Priante sul ”Corriere”, I governi si sono sempre fatti belli sulle imposte nazionali con i bonus, le deduzioni, le detrazioni, le agevolazioni, ma siccome la spesa non è diminuita, i costi alla fine vengono traslati a valle con il taglio dei trasferimenti.
Non si può ignorare come la crescita della pressione fiscale, attestata al 42,8% secondo i dati OCSE, si inserisca in un contesto di debito pubblico elevato – che in Italia si aggira attorno al 150% del PIL – e di persistenti squilibri di bilancio. Questa condizione impone ai governi, sia nazionali che locali, una costante ricerca di fonti di finanziamento, con conseguenze dirette sui cittadini e sulle imprese.
I vari governi, dal centrodestra ai governi di centrosinistra, hanno spesso fatto affidamento su retoriche che promettevano il taglio delle tasse, ma l’evidenza empirica – raffigurata dai dati e dai contributi di esperti come Gabanelli e Priante – mostra come la pressione fiscale sia in realtà aumentata. Tale contraddizione alimenta il malumore degli elettori, creando una percezione diffusa di “scarico” delle responsabilità che, in ultima analisi, grava sui sindaci, costretti a colmare il gap finanziario con nuove imposizioni locali (IRPEF, TARI, IMU).
Un importante tassello di questo complesso mosaico è il fenomeno dell’evasione fiscale, che secondo stime dell’Istat si aggira intorno agli 84 miliardi di euro annui, in un’economia sommersa valutata addirittura sui 182 miliardi. Questi numeri sottolineano come una parte significativa della pressione fiscale sia “invisibile” e come l’inefficienza del sistema di riscossione contribuisca ad aumentare il carico su chi effettivamente paga le tasse, aggravando la disparità tra contribuenti onesti e evasori.
Il passaggio di costi dalla sfera centrale a quella locale non è solo una questione di conti in rosso, ma ha implicazioni dirette sul tessuto economico. L’aumento delle imposte locali può incidere negativamente sulla competitività dei territori, riducendo gli incentivi all’investimento e aggravando le disparità territoriali. In un contesto in cui la competitività italiana è messa a dura prova, la necessità di una riforma fiscale profonda diventa sempre più urgente. Le riforme dovrebbero mirare a semplificare il sistema, ridurre le inefficienze e incentivare la trasparenza, al fine di creare un ambiente più favorevole alla crescita economica e agli investimenti.
L’esperienza italiana suggerisce che una soluzione potrebbe passare attraverso una maggiore autonomia degli enti locali nella gestione delle risorse, bilanciata però da una strategia coordinata a livello nazionale. La proposta di un “fiscal federalism” potrebbe, infatti, consentire di ridurre il carico percepito dai cittadini, garantendo al contempo una distribuzione più equa e mirata delle risorse. Inoltre, l’adozione di tecnologie digitali per il miglioramento della riscossione e il contrasto all’evasione potrebbe contribuire a rendere il sistema fiscale più efficiente e meno oneroso per il contribuente.
L’analisi congiunta di dati economici, studi di settore e testimonianze esperte evidenzia come l’attuale modello fiscale, caratterizzato da una forte pressione sulle amministrazioni locali, sia destinato a creare tensioni a lungo termine. Affinché si possa porre rimedio a questa situazione, è fondamentale un approccio integrato che metta in discussione le retoriche politiche e proponga soluzioni concrete e condivise, in grado di equilibrare esigenze di responsabilità fiscale e sviluppo economico. Solo così si potrà evitare che la “menzogna” delle promesse elettorali si trasformi in una trappola insostenibile per il futuro economico del Paese.