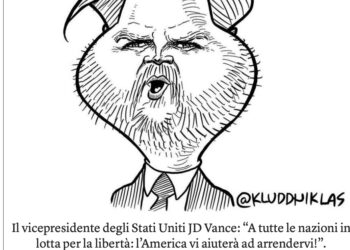Nei mesi di maggio e giugno 2025 si svolge a Palermo un corso di formazione politica dedicato alla violenza sulle donne, promosso dall’Associazione EMILY in partenariato con il Dipartimento di Scienze Psicologiche dell’Università degli Studi di Palermo. Un’iniziativa che si distingue non solo per l’attenzione a un tema drammaticamente attuale, ma per l’approccio strutturale e politico con cui intende affrontarlo.
L’urgenza di questa iniziativa è resa ancora più evidente dal contesto che la circonda: una recrudescenza della violenza di genere, una risposta istituzionale frammentaria, una narrazione pubblica spesso inquinata da ideologie e strumentalizzazioni politiche. Da una parte, la destra politica sembra ridurre la complessità del fenomeno a un presunto “contagio culturale” portato dagli immigrati, evitando accuratamente di nominare la persistenza del patriarcato o i divari strutturali che inchiodano le donne a una condizione di subalternità. Dall’altra, si registra una pericolosa tendenza alla spettacolarizzazione della violenza: si invocano pene esemplari per i femminicidi più efferati, ma si tace sui nodi di fondo — economici, educativi, culturali e politici — che continuano a renderla possibile.
Proprio contro questa ipocrisia istituzionale si scaglia l’analisi di Milena Gentile, presidente dell’Associazione EMILY, che ha anticipato l’iniziativa con parole nette: «Non si può prescindere dall’agire contestualmente su diversi livelli di intervento. Occorre un cambio di passo del sistema nel suo insieme». Una dichiarazione che coglie il cuore del problema: non si tratta di rispondere all’ennesima emergenza, ma di riconoscere finalmente la strutturalità della violenza di genere in Italia.
Un dato su tutti: in Sicilia solo il 15% dei componenti dell’Assemblea Regionale sono donne, e il Parlamento regionale continua a rifiutare la doppia preferenza di genere. È lo stesso squilibrio di potere che genera e alimenta tanto la sottorappresentanza politica quanto i femminicidi: due facce della stessa medaglia. Come denuncia Gentile, l’inerzia davanti a questa evidenza è una forma di complicità.
Il corso EMILY, in questo contesto, si propone non solo come momento di formazione, ma come spazio di elaborazione collettiva per una nuova consapevolezza politica. Non più (solo) rivolto alle donne per prepararli a “resistere” in un mondo politico maschile, ma aperto a entrambi i generi, perché oggi «il malato grave è la relazione». Le parole usate da Gentile vanno al cuore della questione: bisogna destrutturare le radici culturali della violenza, che affondano in aspettative stereotipate, relazioni di potere invisibili, modelli educativi distorti.
A più di un decennio dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, l’Italia non dispone ancora di una legge organica sul contrasto alla violenza di genere. La normativa resta un “arcipelago” disomogeneo, mentre in Spagna da anni è in vigore un sistema integrato che unisce prevenzione, educazione, sostegno economico, formazione professionale, trattamento degli uomini maltrattanti e riforma del sistema giudiziario.
In Italia, al contrario, il sistema si regge su risorse frammentarie e bandi a singhiozzo, senza una pianificazione stabile. E intanto, mentre si invoca il contrasto alla violenza, si tagliano nidi, consultori, rigenerazione urbana e servizi territoriali, esattamente quelle misure che rafforzano l’autonomia economica e sociale delle donne. Un dato su tutti: in Sicilia, l’84% dei ginecologi è obiettore di coscienza, rendendo difficile per molte donne accedere ai diritti sanciti dalla legge 194.
La violenza sulle donne non nasce nel vuoto. Ha radici precise: nella dipendenza economica, nell’assenza di servizi, nella fragilità del sistema di protezione, nella diseguaglianza nei luoghi di potere. E finché la risposta sarà emergenziale, finché non si investirà stabilmente nel sistema pubblico — sanitario, educativo, sociale — la prevenzione resterà una parola vuota.
Il corso EMILY si pone allora come un modello: un percorso che parte dalla formazione per arrivare all’azione politica, con l’obiettivo di costruire una classe dirigente consapevole, capace di affrontare la complessità della violenza di genere non con proclami o pacchetti repressivi, ma con strategie sistemiche, fondate sulla conoscenza, sulla rete tra istituzioni e territorio, e sulla volontà reale di cambiare lo stato delle cose.
Perché, come ha ricordato Gentile, la violenza non si ferma con l’inasprimento delle pene, ma con un nuovo modello di società. E questo modello va costruito, a partire da qui. A partire da Palermo.