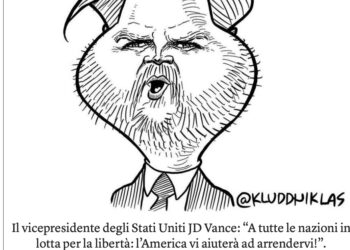C’è un trucco da prestigiatore consumato nell’architettura mediatica del potere postmoderno: trasformare la ferocia in spettacolo, la predazione in farsa, l’autoritarismo in cabaret. È la cifra di Donald Trump, che non è mai stato soltanto un presidente, ma un jocker, nel senso disturbante e lucido che questo termine ha preso nella nostra cultura recente: clown e carnefice, buffone e burattinaio, ridicolo e pericoloso, insieme.
Un clown, certo. Non quello dolce e malinconico del circo, ma il jocker postmoderno: sregolato, irriverente, bulimico, narciso, pieno di tic e smorfie, affamato di risse, sgrammaticato, febbrile. Uno che ha imparato a occupare lo spazio pubblico con la mimica del dileggio e il ritmo sincopato del caos. Un corpo politico che si contorce come un tweet: breve, aggressivo, compulsivo. Ma dietro al narcisismo trash c’è la spina dorsale del predatore: lo sguardo freddo dell’uomo d’affari, la logica dell’acquisizione, l’istinto della fagocitazione.
Per questo Trump non si combatte con l’ironia – ci sguazza – né con la denuncia morale – se ne ciba. È l’equivalente politico di un virus narrativo: muta, infetta, resiste. E nella sua versione rinnovata post-2020, potenziata dalla mitologia del martire e dall’endorsement trasversale del denaro e del rancore, è più efficace di prima.
Nei suoi primi cento giorni, l’obiettivo di Donald Trump non è stato né la sicurezza nazionale né la pace né l’identità del popolo americano. È stato, semplicemente, il patrimonio. Il proprio. Quello della famiglia, degli amici, dei soci, dei comprimari. La macchina dello Stato trasformata in catapulta per gli affari privati. Non una distorsione, ma un progetto: altalena dei dazi e bit-coin grazie all’abbattimento delle regole.
La classe dirigente che lo circonda – dai Kushner ai Miller, dai Vance ai compari miliardari disseminati nei gangli delle amministrazioni e dei think tank – è organica a questo sistema. Non parliamo solo di politici, ma anche di manager del profitto geopolitico. La politica estera? Un vettore per accordi energetici. La politica migratoria? Uno spettacolo per la base elettorale e un’occasione per privatizzare i centri di detenzione. L’ambiente? Un fastidio da deregolarizzare. Ogni asset statale è un banco da gioco. Ogni alleato, un potenziale partner. Ogni nemico, un’occasione di branding.
Ma se il predatore è prevedibile, la questione più bruciante è un’altra: perché continuiamo a lasciarlo cacciare indisturbato o, addirittura, giuriamo fedeltà all’amico americano meno affidabile di sempre?
In Italia, dove il culto dell’uomo forte ha da sempre un appeal trasversale, Trump gode di ampi consensi. Non tanto per ciò che fa, ma per ciò che incarna: l’idea che la politica sia guerra, che l’onestà sia un optional da anime belle, che l’astuzia conti più della legge. “Se ha vinto, quindi può fare ciò che vuole” è la versione degradata del vecchio fiat voluntas principis. Non c’è più bisogno di ideologia: basta la forza, il carisma, l’efficienza nel farsi i propri comodi senza farsi fregare. Questa è la vera infezione: l’ammirazione., l’identificazione. Il provincialismo geopolitico che fa dell’Italia il Paese in cui si invidia il predatore, lo si invita, lo si copia, mentre smantella ogni senso di limite istituzionale, ogni controllo sul potere, ogni dignità dell’autonomia europea.
In Groenlandia, in Canada, in Australia, i trumpisti locali sono stati battuti. In Europa, invece, i varchi si aprono, in Italia e altrove. Il feeling con Putin non è solo strategico, ne solo estetico: se entrambi condividono un amore antico per la forza impunita, le “liaisons” affondano in una storia torbida di oligarchi affaristi, compromessi, algoritmi e prestanome. Una grammatica del potere che oggi sta contaminando le democrazie, facendo leva sulle loro debolezze: la sfiducia, il risentimento, la crisi dell’istruzione critica.