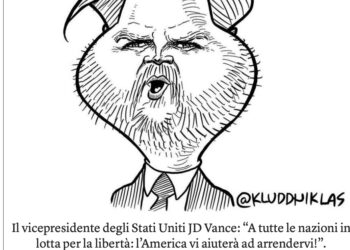Nel cuore della cristianità, sotto la cupola possente di Michelangelo, si era celebrato — con discrezione degna della migliore diplomazia pontificia — un incontro che, nei secoli passati, sarebbe forse stato tramandato come “miracolo”. Due sedie, poste con cura in un angolo della Basilica di San Pietro, lontano dai flash e dalle cronache ufficiali, hanno accolto i protagonisti di un faccia a faccia tanto improvviso quanto simbolicamente carico. Nessun altare, nessuna benedizione. Solo silenzio, occhi negli occhi, e un’intesa che, secondo indiscrezioni insistenti, avrebbe sancito l’accesso americano alle ricchezze minerarie dell’Ucraina come compenso, o contropartita, per la protezione militare garantita contro l’aggressione russa. Zelensky ha subito il pizzo e Trump ha incassato l’affaire? L’Ucraina è più potetta, la pace è più vicina?
Il confessionale — se così si può chiamare quel sobrio allestimento — ha offerto lo sfondo a una delle pagine più disilluse della diplomazia contemporanea. Non un luogo di pentimento, ma di accordi. Non un patto con Dio, ma con il dollaro. L’indomani, con una puntualità quasi liturgica, l’accordo è stato formalizzato. Il tempismo ha lasciato l’amaro in bocca anche ai più esperti osservatori: non tanto per la sostanza dell’intesa, quanto per la velocità con cui essa ha neutralizzato ogni residuo di suggestione spirituale, ogni possibile illusione di un mondo guidato ancora da altro che dal tornaconto.
Trump, con il suo senso infallibile per l’affare, pare abbia garantito protezione militare in cambio di accesso prioritario alle terre rare. Ma in controluce si insinua un sospetto più sottile: che il vero obiettivo non sia la difesa dell’Ucraina, bensì un’intesa parallela con Putin, una spartizione del bottino, una condivisione fredda delle ricchezze di una nazione che ancora rivendica la propria indipendenza mentre viene, con metodica astuzia, trasformata in zona franca per gli interessi altrui.
Il miracolo, quello vero — se mai c’è stato — è durato poco. Quarantotto ore, dicono i più cinici. Giusto il tempo perché la stampa internazionale accendesse e spegnesse i riflettori, e perché i fedeli, per un attimo, pensassero che la politica potesse chinarsi davvero alla logica del sacro. La verità è che i miracoli non esistono più — o forse esistono, ma senza destinatario. Accadono in silenzio, e non ce ne accorgiamo. Più spesso, accade il contrario: li invochiamo senza crederci davvero. Non è un’accusa alla modernità, né una nostalgia dei segni. La struttura simbolica del miracolo, che una volta reggeva interi mondi, ha perso la sua grammatica. Si parla di miracoli laici in politica, in economia, perfino in medicina, ma sempre per indicare ciò che sfugge alle nostre categorie razionali, non ciò che le supera. Il miracolo non è più l’irruzione dell’invisibile: è la scorciatoia narrativa che prende il posto della spiegazione. E’ diventato sinonimo di altro.
Nel mondo occidentale — quello che per secoli ha fondato la propria coscienza su una promessa salvifica — il bisogno del miracolo è diventato una nostalgia sorda, senza fede. Una specie di superstizione colta. Ne sentiamo la mancanza come si sente la mancanza di qualcosa che non si è mai davvero posseduto. Lo desideriamo, ma non lo consideriamo possibile. Per questo si parla tanto di miracoli e non ne accade nessuno. I miracoli, per avvenire, devono essere creduti. E noi abbiamo disimparato a credere.
Del resto i miracoli, è noto, non si impongono: pretendono di nacsre su un terreno fertile, la fede. E oggi il mondo, forse, non ha più spazio per la fede. O meglio: ne ha, ma la rivolge altrove.
San Pietro resta al suo posto, imperturbabile. Ma chi vi ha parlato, sotto voce, lo ha fatto per stringere mani, non per sciogliere peccati. La politica estera americana, sempre più simile a un bazar globale, ha imparato a usare anche i luoghi santi come scenografia. Non con blasfemia, ma con astuta indifferenza.