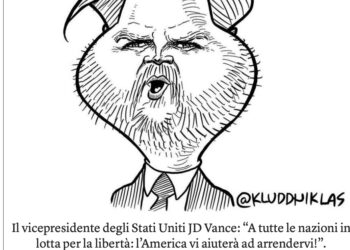C’è una storia ufficiale dell’Italia repubblicana: quella delle istituzioni, dei partiti, delle elezioni, dei compromessi sociali, della Costituzione nata dalla Resistenza. Una storia vera, ma incompleta.
E poi c’è una storia parallela: fatta di basi militari segrete, operazioni coperte, golpe sussurrati, apparati deviati, criminalità tollerata, leader sacrificati. Quanto è stata davvero sovrana l’Italia dal dopoguerra a oggi?
Il vincolo con gli Stati Uniti, nato come alleanza per la libertà, si è trasformato – in molti momenti cruciali – in una relazione di tutela, controllo e condizionamento strutturale. Nel nome dell’atlantismo, e per scongiurare il “pericolo rosso” incarnato dal Partito Comunista Italiano, l’Italia è diventata una repubblica sorvegliata:– occupata militarmente nelle sue basi;– vigilata dai suoi stessi servizi deviati;– corretta ogni volta che tentava di uscire dal tracciato.
Gli Stati Uniti, con la complicità di élite italiane consenzienti, hanno considerato il nostro Paese una frontiera instabile da stabilizzare con ogni mezzo necessario. L’Italia era troppo esposta, troppo grande, troppo “rossa” per essere lasciata libera di decidere.In questo contesto, la nostra democrazia è sopravvissuta, ma on una cessione di sovranità che con Trump ha registrato una evoluzione esponenziale.
I principali strumenti di questa sorveglianza, legati tra loro da un filo invisibile ma resistente:
- Le basi militari e nucleari, che hanno trasformato il territorio italiano in un deposito strategico USA.
- I tentativi di colpo di Stato e la strategia della tensione, usati per terrorizzare l’opinione pubblica e frenare il cambiamento.
- La rete Gladio e i servizi segreti paralleli, che hanno operato al di fuori del controllo democratico.
- Il caso Moro, simbolo della sovranità repressa: un uomo e un progetto eliminati per evitare che il PCI arrivasse al governo.
- Il rapporto con la mafia, usata come braccio informale del potere, tollerata finché utile, mai completamente sradicata.
La posta in gioco non è soltanto storica. Nel tempo, il meccanismo si è trasformato, ma non dissolto: dalla sorveglianza militare si è passati al controllo tecnologico, dall’anticomunismo al post-democratico algoritmo, dalle valigette nucleari al potere delle piattaforme. La domanda, oggi, è la stessa di ieri: siamo un Paese che partecipa alla storia o un Paese che la subisce?
Recuperare memoria, svelare le zone grigie, rileggere criticamente i “non detti” della Repubblica è un passo necessario. Non per nostalgia o risentimento. Ma per capire che tipo di libertà politica ci resta. E se vogliamo ancora esercitarla.
(L’articolo è stato elaborato con il supporto dell’IA)