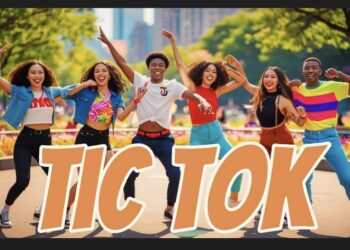C’è una logica ferrea, quasi darwiniana, che attraversa tutto ciò che sta accadendo da quel 7 ottobre 2023 in poi: la “Dottrina della Forza”. Non è solo la scelta di colpire – e di continuare a colpire – Gaza con una potenza che ha già causato oltre 55 mila morti palestinesi, per metà donne e bambini, mentre i superstiti disputano un sacchetto di farina sotto il fuoco dei cecchini. È, soprattutto, la pretesa di tradurre la sicurezza in dominio permanente, fino al miraggio di un “regime change” a Teheran, oggi bombardata da raid israeliani con il plauso di Washington che evoca la resa incondizionata dell’Iran.
La Forza, in questa dottrina, non conosce limiti né contropartite umanitarie: ogni spazio di dignità civica del popolo palestinese – a Gaza come in Cisgiordania – diventa un bersaglio “collaterale”. Così gli ostaggi israeliani, deglutiti da mesi nei meandri di Hamas, si trasformano in moneta di scambio nella diplomazia del terrore; e i raid oltre confine sanciscono un espansionismo senza confini, destinato a far implodere l’ordine regionale.
Ma la Dottrina della Forza non resta chiusa nell’anello di fuoco mediorientale. Come un virus, l’uso politico della paura migra dai regimi illiberali alle democrazie mature, infiltra i loro gangli istituzionali e muta l’opinione pubblica in platea intimidita. Israele la utilizza senza remore anche al proprio interno, riducendo a “quinta colonna” chi critica l’operazione a Gaza. Negare la complessità diventa così parte integrante dell’offensiva: la democrazia, come ricordava un vecchio adagio, “non si esporta con i cannoni”; e tuttavia l’autoritarismo viaggia leggero, sospinto dall’adrenalina dell’emergenza. La memoria dei diritti è lenta e faticosa, il veleno della paura rapido e pervasivo.
Più crescono le debolezze politiche, più ruggiscono i cannoni. Nell’America di Donald Trump – che l’economista Paul Krugman definisce ormai un caso di competitive authoritarianism – l’entropia istituzionale si traduce in minaccia di nuovi conflitti: “sostegno illimitato” a Israele, opzione militare contro l’Iran, sabotaggio di ogni mediazione multilaterale. A riempire il vuoto lasciato da Washington (debole con i forti, Russia e Israele; forte con i deboli, Ucraina) accorrono potenze regionali che giocano su più tavoli: l’Arabia Saudita dell’erede bin Salman, corteggiata dagli Accordi di Abramo ma riluttante davanti alle stragi di civili; la Turchia di Erdoğan, che strilla al genocidio ma commercia droni e gas con chiunque. Nel frattempo l’Europa, infiltrata da stati filo russi (Ungheria) e sottomessa all’instabile Presidente USA (Italia) sussurra, balbettando fra “diritto alla difesa” di Israele e “uso sproporzionato della forza”
La pistola sul tavolo conta più della risoluzione Onu. In questo contesto le reti di disinformazione russe – dalle clone-news dell’operazione “Doppelganger” agli ipervirali deep-fake che colpiscono perfino la première dame francese – approfittano della stanchezza occidentale per ridefinire le narrazioni. Soprattutto sulla guerra di Gaza, un pezzo di pubblico europeo si lascia sedurre da un cinismo “equidistante” che finisce per assolvere anche le invasioni di Putin in Ucraina: se tutto è “relativo”, nulla è più imperdonabile.La Dottrina della Forza trova qui il suo meno vistoso, ma ugualmente letale, alleato: un ecosistema mediatico dove fatti e menzogne coesistono, mescolandosi in un brown noise che smorza l’indignazione. E mentre si discute se Israele stia oltrepassando la linea dell’apartheid o della “pulizia etnica”, il campo profughi di al-Mawasi brucia e le ruspe annunciano nuovi insediamenti in Cisgiordania.
Cosa resta allora dell’Occidente? Krugman affida proprio all’Europa – per quanto indebolita – il ruolo di ultimo baluardo democratico. Ma un baluardo non può reggersi sullo status quo ante: servono idee chiare. Serve la capacità di dire che il diritto internazionale, se vale per Hamas, vale anche per Tsahal; che la sicurezza di Israele non può fondarsi sulla negazione perpetua di uno Stato palestinese; che il soft power europeo non è un alibi per l’inerzia, bensì la condizione per un ordine multilaterale alternativo alla legge del più forte.
(Nell’elaborazione dell’articolo mi sono servito del supporto dell’IA)