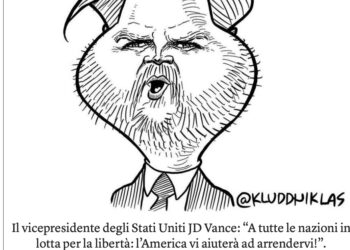Nel nostro tempo, la parola “trasformismo” appare quasi desueta, buona per storici del parlamentarismo ottocentesco o per editorialisti in vena di aforismi. Ma oggi non basta più. Il caso raccontato da Corrado Formigli su La7 — la “transumanza” di alcuni ex parlamentari del Movimento 5 Stelle dal banco dell’opposizione intransigente agli uffici ovattati del lobbismo militare — non è trasformismo: è trasfigurazione sistemica. E ciò che inquieta non è tanto la traiettoria, quanto la naturalezza con cui essa si è compiuta.
Due sigle, Loran e Deas, diventano in questa narrazione i vettori di un paradosso che non è più tale, ma piuttosto regola implicita dell’ordine vigente: l’oscillazione tra moralismo integralista e cinismo operativo. Entrambe le società sono accreditate presso il Ministero della Difesa e partecipate da ex deputati grillini, alcuni dei quali militavano in Commissioni parlamentari competenti in materia. La logica è evidente, brutale nella sua semplicità: si passa con disinvoltura da un ruolo pubblico, dove si esercitava il diritto-dovere di scrutinare il sistema militare-industriale, a un ruolo privato che di quel sistema trae profitto, influenza e rendita.
La vicenda non è solo italiana, ma l’Italia ne esalta le ambiguità. Perché i protagonisti, in questo caso, sono quelli che avevano eretto la loro credibilità su un impianto etico-ideologico intransigente: l’onestà come valore identitario, il rifiuto delle élite, il disprezzo per i “mestieranti” della politica, la denuncia della corruzione morale del sistema. il disarmo…disarmante, In breve: la pretesa di una diversità antropologica. Eppure è proprio questa differenza a essersi dissolta nella più classica delle continuità sistemiche. In nome di una competenza tardivamente acquisita — e puntualmente remunerata — i “puri” si sono scoperti “esperti”, e la guerra è diventata, da scandalo da denunciare, una filiera da ottimizzare.
Questa parabola interroga non solo la coerenza dei singoli, ma anche la struttura delle carriere politiche nell’Italia della seconda (e terza) Repubblica. Non vuole suscitare una indignazione particolare verso un ambiente politico, né infierire su uno schieramento che ha dentro di sé, come ogni altro, anticorpi e passioni civilì. Semmai suggerisce una comunicazione che non smasrrisca la realtà,la concretezza, la governance piuttosto che la creazioni di aspettative elusive, buone solo a fidelizzare folle plaudenti attraverso sfuggenti onde emotive.
Il salto dal Parlamento al lobbismo del resto non è nuovo — il caso di Crosetto, passato da rappresentante di Leonardo SpA a Ministro della Difesa, è emblematico — ma ciò che colpisce è la rapidità con cui l’etica del servizio pubblico si dissolve in un mercato delle competenze che premia la prossimità, non il merito. Non è una questione di “porte girevoli”, è un sistema a circuito chiuso, che metabolizza anche i corpi estranei: i pentastellati, nati per aprire le istituzioni “come una scatoletta di tonno”, si sono scoperti custodi del tonno in scatola.
Accadde anche a Massimo D’Alema, che ha tentato (maldestramente) di fare da intermediario nella vendita di armamenti all’estero; la rilevanza politica di Dalema è utile non tanto per misurare la distanza ideologica che lo separa dai nuovi lobbisti, quanto per segnalare la continuità trasversale di un sistema in cui l’exit dalla politica si consuma sempre più spesso nell’ambito opaco delle relazioni industriali, finanziarie, militari. Nessuna colpa, ma un’ambiguità che genera sfiducia, alienazione, cinismo sociale.
C’è qualcosa di profondamente inquietante nel modo in cui la difesa — cioè le armi — è diventata non solo materia di business, ma anche l’approdo naturale di carriere politiche interrotte. Non si passa più dal Parlamento all’università o alla società civile, ma direttamente al procurement, alla consulenza, alla logistica bellica. È il sintomo di una mutazione più profonda: la capacità del potere economico e militare di assorbire ogni dissenso, ogni voce alternativa, ogni anomalia. Anche i più intransigenti cedono, non perché corrotti, ma perché sconfitti e smarriti, allora c’è da chiedersi se davvero esista ancora un “fuori” dal sistema. O se, al contrario, la scatoletta di tonno si sia rivelata un barattolo da emporio bellico, ben confezionato e pronto per l’export.