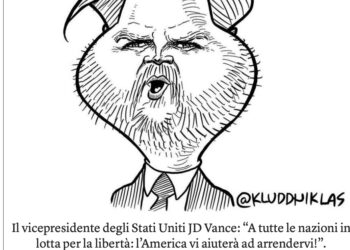Il 2 agosto 216 a.C., presso Canne, in Puglia, l’esercito cartaginese guidato da Annibale infliggeva alla Repubblica Romana la più cocente delle sconfitte. Venticinque secoli dopo, nella stessa località, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha deposto fiori ai piedi di una stele eretta nel 1939 dal regime fascista e ha celebrato il “Duemiladuecentoquarantunesimo anniversario” della battaglia. Il gesto, condiviso con solennità sui social, ha suscitato interrogativi e riflessioni, non tanto per il fatto in sé quanto per il suo evidente carico simbolico. «I luoghi in cui la cultura esprime se stessa e la propria identità, sono l’unico autentico contravveleno alla discordia e alle guerre di ogni ordine e grado», ha scritto il ministro.
Non una semplice commemorazione archeologica, dunque. Piuttosto, un’operazione pubblica e culturale che, nella sua apparente eccentricità, riflette fedelmente una visione del mondo. Quella di una destra identitaria, in dialogo con i miti fondativi della romanità e con il peso tragico della sconfitta.
Il gesto di Giuli può apparire paradossale: perché celebrare una disfatta? La risposta va cercata nella genealogia culturale della destra italiana postfascista. Nella sua mitologia, la sconfitta non è ignominia, ma trasfigurazione. Non è fallimento, ma epica.
La battaglia di Canne, come l’epilogo di Alarico, Caporetto o l’epopea della RSI, rientra in quella categoria di eventi che esaltano l’eroismo anche laddove la vittoria viene meno. Il nemico — in questo caso Annibale — può essere riconosciuto come genio militare, persino ammirato, se ciò contribuisce a edificare una narrazione tragica, alta, romana nella forma e nello spirito.
L’accoglienza delle sconfitte come forma di grandezza è una linea profonda nella cultura della destra radicale, dove il martirio e la “bella morte” non sono una deviazione estetizzante, ma una struttura portante della narrazione morale.
Al centro della scena si erge una colonna: la stele commemorativa voluta nel 1939 dal regime fascista. Non è una presenza neutra. In pieno progetto imperialista e in un contesto di riscrittura del passato, il fascismo non si limitava a restaurare rovine: le usava. Ogni scavo, ogni stele, ogni epigrafe veniva integrata nel disegno politico-culturale del regime.
Quella di Canne non fa eccezione. È un monumento che incarna la strategia fascista di rifondazione simbolica attraverso la romanità. Anche una disfatta — purché virile, cruenta, tragica — poteva servire a cementare l’identità nazionale. L’eroismo del soldato romano caduto diveniva specchio e archetipo del combattente fascista.
Giuli, intellettuale raffinato e consapevole dei simboli, ha scelto proprio questo luogo per un gesto di memoria pubblica. Un atto che, lungi dall’essere nostalgico o accidentale, riattiva consapevolmente quella genealogia estetico-ideologica. Nessuno sberleffo, nessun revisionismo esplicito. Ma una silenziosa continuità simbolica con un certo impianto di cultura nazionale.
C’è un’ultima chiave di lettura, più audace, ma non meno plausibile. È possibile leggere la commemorazione come una metafora: l’Italia di oggi come la Roma di allora. Un corpo politico incapace di interpretare il territorio, cieco dinanzi alla strategia dell’altro, condannato alla sconfitta per eccesso di fiducia.
Lo strano caso del vice capo del governo filo-italiano, che si prende il plauso del..nemico
Il plauso a scena aperta del Cremlino al Vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha suggerito al plaudito di ricordare...