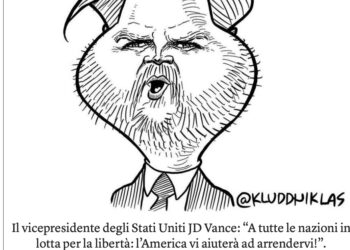Claudio Cerasa, su Il Foglio (12.8.25), rompe un tabù, portando nel dibattito pubblico uno scenario che nelle cancellerie europee è dato per concreto: entro il 2030, un conflitto tra la Russia e la Nato non è fantascienza, ma eventualità per la quale bisogna prepararsi ora. Lo chiamano readiness, prontezza: un piano di riarmo che non si deve chiamare riarmo.
Cerasa elenca fatti, non suggestioni: ex ministri della Difesa, capi dei servizi segreti e vertici Nato – da Pistorius a Kahl, da Bauer a Bydén – convergono su una finestra temporale tra il 2027 e il 2030. Segnali convergenti: Mosca non crede più nella deterrenza dell’articolo 5 Nato; ricostruisce arsenali a ritmi industriali; e una resa dell’Ucraina aprirebbe all’esercito russo un decennio di preparazione indisturbata. Nel frattempo, gli Stati Uniti di Trump – se confermeranno le tendenze annunciate – potrebbero spostare il baricentro strategico sull’Indo-Pacifico, lasciando l’Europa esposta e meno difendibile.
Il Kiel Institute for the World Economy quantifica la sfida: triplicare o sestuplicare la produzione di sistemi terrestri, rafforzare difese aeree, integrare AI e droni, ridurre le dipendenze industriali. La deterrenza, dicono, funziona solo se è visibile, pianificata e sostenuta da un’industria in grado di mantenere la promessa. Il riarmo non come preludio alla guerra, ma come assicurazione sulla pace.
Fin qui, la logica è ferrea: in un sistema internazionale in cui la forza è ancora moneta di scambio, chi non dimostra di poterla usare rischia di essere travolto. Eppure, resta la domanda: questo scenario è davvero inevitabile o lo stiamo rendendo tale proprio perché lo assumiamo come orizzonte? Il 2030 distopico – con l’Europa trasformata in un gigantesco campo trincerato – è un esito possibile, ma non predeterminato. La previsione si fonda su tre elementi che, pur solidi, sono variabili: la scelta strategica americana, l’evoluzione interna della Russia e la capacità europea di usare la diplomazia non come foglia di fico, ma come strumento reale di contenimento. La storia insegna che prepararsi alla guerra può scoraggiarla, ma può anche innescare una spirale di azioni e reazioni in cui la profezia si autoavvera.
L’urgenza, allora, non è solo industriale e militare, ma politica e culturale: capire se l’Europa può difendersi senza diventare ciò che dice di voler evitare, se può dotarsi di forza senza farsi schiava della logica della forza. Il rischio è di trovarsi invischiati nella logica bellicista che abbiamo evocato noi stessi.