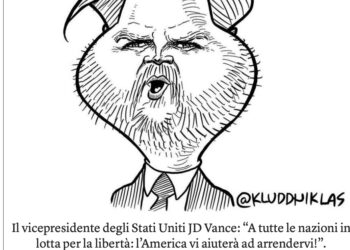Nell’arco di quattordici mesi, il governo guidato da Giorgia Meloni ha introdotto 62 nuovi reati. Il primo pacchetto ne ha contati 48, l’ultimo, di recente approvazione, altri 14. Un numero notevole, soprattutto in assenza di un contesto emergenziale. I dati forniti dal Ministero dell’Interno e dall’Istat indicano una tendenza alla diminuzione della criminalità: -5,8% di reati complessivi nel 2023 rispetto all’anno precedente, con cali significativi in furti, rapine, danneggiamenti. A crescere è invece la percezione di insicurezza, alimentata da un linguaggio politico che insiste su ordine, controllo e repressione.
È dentro questo paradosso – meno crimini, ma più leggi penali – che si sviluppa una strategia legislativa coerente: aumentare gli strumenti di controllo, allargare l’area della punibilità, restringere le aree del dissenso. Particolarmente significative le nuove disposizioni contenute nel decreto legge sulla sicurezza approvato a fine marzo 2025. L’articolo 5 introduce pene fino a 6 anni per chi “impedisce con violenza lo svolgimento di manifestazioni autorizzate”, con un evidente effetto dissuasivo anche verso proteste pacifiche. L’articolo 8 prevede aggravanti per l’occupazione non autorizzata di edifici pubblici, mentre l’articolo 11 rafforza i poteri di sorveglianza e intercettazione dei servizi di sicurezza.
Proprio i servizi segreti, in virtù della modifica dell’articolo 4 della legge 124/2007, possono ora accedere in via preferenziale a materiale sensibile raccolto da operatori dell’informazione, anche senza provvedimenti dell’autorità giudiziaria. È questo il contesto della denuncia del giornalista Sigfrido Ranucci, che ha segnalato una circolare interna della Rai in cui si dispone la tracciabilità obbligatoria di tutto il materiale video prodotto da giornalisti, freelance e troupe esterne. I servizi avrebbero diritto a richiederlo integralmente, a fini “di sicurezza nazionale”.
Si tratta di una disposizione senza precedenti nel servizio pubblico, che mina alle fondamenta la tutela delle fonti, sancita dall’articolo 2 del Testo unico dei doveri del giornalista, e riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Goodwin vs UK, 1996) come principio fondamentale della libertà di stampa. La posizione dell’Italia nella classifica 2024 di Reporters sans frontières conferma una tendenza preoccupante: 46° posto su 180 paesi, fanalino di coda tra le democrazie del G7, e peggio di nazioni come Namibia e Sudafrica.
Nel frattempo, l’indirizzo editoriale della Rai, in particolare su Rai 1 e Rai 2, mostra un crescente allineamento alla narrativa dell’esecutivo. In prima serata si registra una riduzione della pluralità dei punti di vista e una selezione degli ospiti più orientata a sostenere l’azione di governo. Le proteste di alcuni giornalisti della terza rete e le segnalazioni dell’Usigrai non hanno prodotto interventi significativi da parte del CdA.
Questi episodi non sono slegati. La linea è unica, ed è quella dell’accentramento del potere. La figura dell’esecutivo emerge come superiore agli altri poteri costituzionali. La magistratura, oggetto di frequenti delegittimazioni pubbliche, viene descritta come un freno. Il Parlamento appare ridotto a luogo di ratifica. I corpi intermedi (associazioni, sindacati, stampa) sono visti come ostacoli da aggirare, non come interlocutori. È l’idea di “governo forte” che diventa sinonimo di “governo solo”.
Questa concezione si fonda su un presupposto: il mandato popolare come autorizzazione incondizionata. L’elezione diventa una sorta di investitura plebiscitaria, che giustifica l’eliminazione di lacci e lacciuoli. Ma è proprio questo il punto critico. La democrazia liberale si regge non solo sul consenso, ma sui contrappesi. La separazione dei poteri, l’indipendenza della magistratura, il pluralismo informativo, la libertà di manifestare non sono orpelli: sono architravi. L’efficienza decisionale non può tradursi in supremazia.
Siamo ancora in una fase iniziale. Ma i segnali sono inequivocabili. La centralizzazione del potere esecutivo, l’espansione dell’apparato sanzionatorio, la compressione del dissenso e la crescente pressione sull’informazione delineano un cambio di paradigma. Una democrazia sorvegliata non è necessariamente una democrazia sicura. E quando lo Stato si dota di troppi strumenti per controllare, lo fa a spese della democraza.