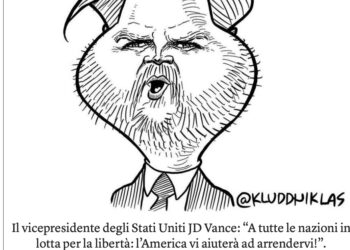Mai come in questo tempo lo zeitgeist, lo spirito dei tempi, insidia lo Spirito Santo. Non si tratta di una semplice antitesi retorica, ma della constatazione di una tensione reale e crescente tra la volatilità delle mode culturali globali e la permanenza del messaggio cristiano. Un vento tumultuoso travolge categorie etiche tradizionali, dissolvendo i confini della civiltà come patto e della convivenza come orizzonte condiviso. IL messaggio spirituale è sottile, silenzioso, esigente: un soffio che invita all’ascolto, non alla reazione.
Nel cuore di questa tensione si colloca il Conclave, momento rituale e decisionale che – paradossalmente – proprio nella sua antichità rivela la sua attualità. A precederlo, però, non è stata una vigilia raccolta ma un gesto grottesco: il fotomontaggio virale dell’uomo più potente del mondo, che si è fatto papa nel cyberspazio. Un’iconografia generata dall’intelligenza artificiale che ha dileggiato, consapevolmente o no, il simbolo del potere spirituale, rendendolo estetica e consumo. Un’indicazione inquietante: la sacralità può oggi essere simulata, consumata e svuotata prima ancora di essere intesa.
In questo clima, i cardinali che si apprestano a entrare in Conclave dovranno compiere un atto di discernimento che non è soltanto ecclesiale, ma antropologico e culturale. Si tratta di comprendere se il futuro della Chiesa consista nell’assecondare lo spirito dei tempi, interpretandolo in chiave pastorale, oppure nel costruirvi un argine, riaffermando una posizione controcorrente. Entrambe le strade comportano rischi: nella prima si profila l’assimilazione, nella seconda l’irrilevanza. Ma la sfida più profonda è un’altra: distinguere il vero dal falso spirito. Come ammonì Benedetto XVI, “non è che lo Spirito Santo guidi la penna dei cardinali… evita che si facciano sciocchezze”. Ovvero: il divino non garantisce l’infallibilità del processo, ma solo l’argine contro l’abisso.
Non va trascurata la nuova geografia del Sacro Collegio. La cattolicità, per secoli incardinata nei codici culturali dell’Europa latina, si è globalizzata: l’Africa, l’Asia, l’America Latina non sono più periferie, ma nuovi centri teologici, linguistici, liturgici. Questa pluralità è insieme risorsa e insidia: può rinnovare la visione, ma anche far emergere contraddizioni profonde, talora incompatibili. Il Conclave sarà dunque anche una prova di cosmopolitismo ecclesiale: fino a che punto l’universalità è capace di tenere insieme le diversità?
Il Vaticano non ha un esercito, ma conserva un peso che supera di gran lunga la sua dimensione materiale. La popolarità trasversale di papa Francesco, come testimoniato dai suoi funerali, è segno che la Chiesa resta interlocutrice attiva anche per il mondo secolarizzato. Roma continua a essere guardata come un baricentro simbolico. Qui, potere spirituale e potere temporale non si fondono, ma si osservano. E in un’epoca di conflitti e disorientamenti, potrebbero convergere nel bisogno condiviso di una grammatica della pace.
La posta in gioco, allora, non è solo ecclesiale. È l’identità stessa dell’umano in una stagione di metamorfosi. E se è vero che il Papa non è un profeta, è altrettanto vero che la sua elezione può essere il segnale di una profezia collettiva: la possibilità di un ordine che non sia solo pragmatico, ma anche giusto; non solo globale, ma anche buono.