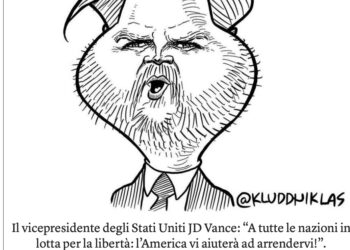Un comignolo, solo un comignolo, contende alla “devota magnificenza di uno spettacolo superbo” e al potere mediatico, la scena. Non vince, non perde: è il suggello di un potere reale. Ad esso guarda il mondo smarrito degli ultimi e quello dei potenti, che arretrano davanti all’impalpabile enigma della fede. Il segnale di fumo, che da esso fuoriesce, sospende il tempo. Emana un dominio silenzioso, che non ha bisogno di esprimersi, perché è già linguaggio, è già il messaggio. In un’epoca in cui tutto deve essere spiegato subito, impone il mistero. Non produce contenuto, produce senso. Non dice chi, non dice quando: dice che sta accadendo qualcosa. Qualcosa su ciò che manca. Ed è sufficiente.
Paradossalmente, detta un tempo nuovo proprio tornando a uno tempo arcaico. Il tempo dell’oracolo, dell’ambiguità, dell’incomprensibile. L’equivalente visivo di una frase sospesa. È un “forse”, un “non ancora”, un “sta accadendo”.
Nelle democrazie esauste, nelle leadership spettrali, nei partiti liquidi, la figura del Papa – eletta in segreto – funziona come simulacro di ciò che la politica ha smarrito: il peso simbolico della decisione, la sacralità del consenso. Non importa che la Chiesa sia percorsa da divisioni: importa che la liturgia del conclave, con le sue regole e la sua teatralità minuziosa, parli ancora all’immaginario globale.
Il comignolo diventa così un medium, in senso stretto: ciò che sta in mezzo tra il potere e il popolo, tra la volontà e la sua manifestazione. È un’interfaccia primitiva che batte ogni innovazione. Twitter può anticipare i nomi, ma non può generare il momento.
In questo cortocircuito tra l’alta teologia e la comunicazione c’è un avvertimento anche per i nuovi padroni del discorso. Musk, Zuckerberg, X, Threads, Meta, la loro egemonia si regge su quantità e controllo. Il segnale di fumo, invece, è intraducibile. Non è monetizzabile, perché non è interpretabile. È una forma di autorità che non chiede il like. Il comignolo, quindi, non è un residuo. È un’anomalia funzionale. La sua resistenza non è nostalgia, ma ipermodernità. La sua forza non è nella verità che proclama, ma nel mistero che impone. Per questo il mondo lo guarda e gli si affida.