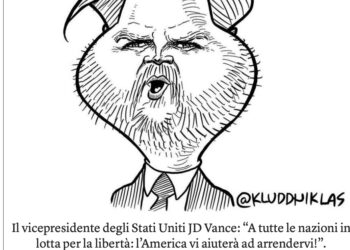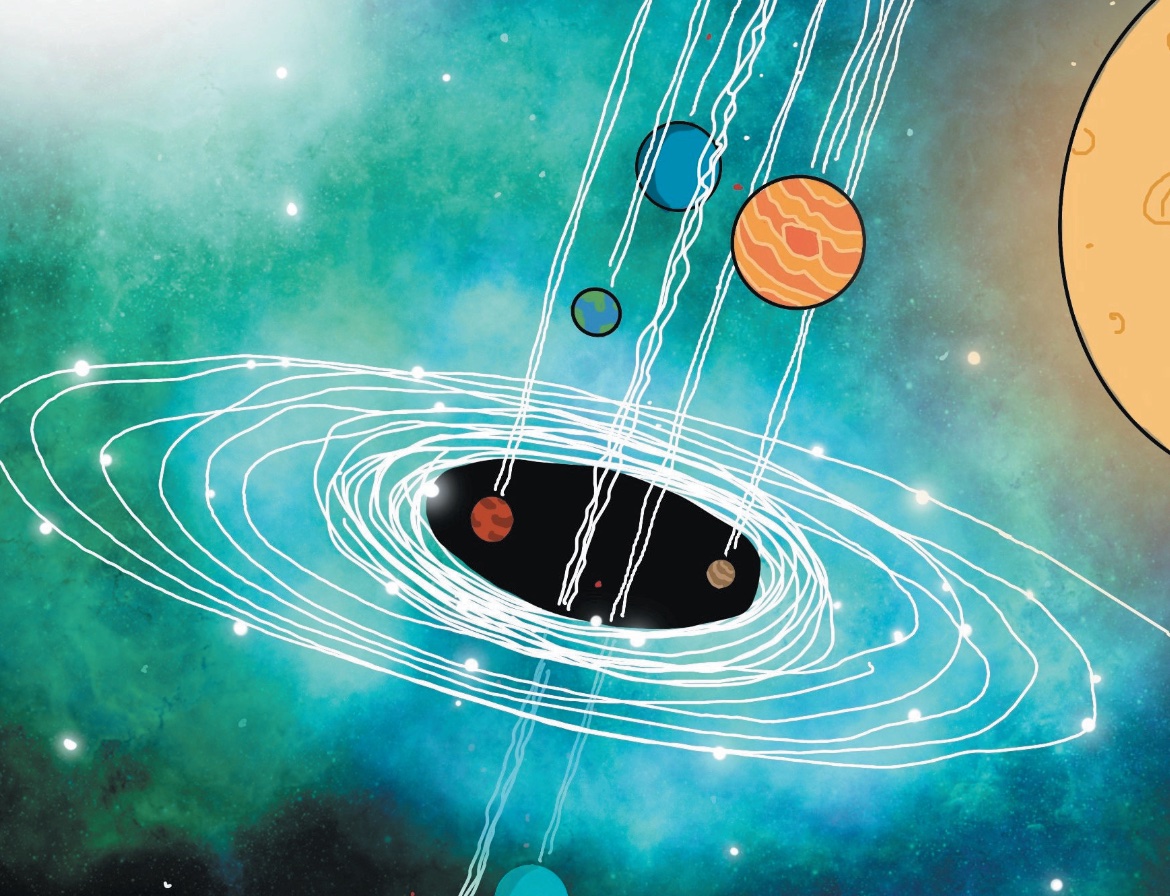Trump ha deciso che il ministero della Giustizia, e negli Stati Uniti quel dipartimento dell’esecutivo che ha il comando costituzionale sui procuratori e indirizza le loro scelte con un margine forte di arbitrarietà o insindacabilità, deve essergli leale e deve conformarsi al suo potere esecutivo in funzione del mandato popolare ottenuto con il voto. (Giuliano Ferrara, Il Foglio, 24.2.25)
La condanna di Marine Le Pen ha ribadito uno dei precetti ormai distintivi della estrema destra emergente :italiana, europea, russa e nordamericana. Annalisa Cuzzocrea, (La Repubblica, 1.4.25), sintetizza con efficacia :Nella visione di Salvini, che è quella dei patrioti europei, di Le Pen, di Orbán, ma anche di Putin, di Musk, di Bannon o Alexander Dugin, per andare alle radici filosofiche del sovranismo mondiale, l’eletto dal popolo può tutto. Non ha vincoli, non deve sottostare alla regola. E chi lo richiama a farlo è un traditore della volontà democratica, un giudice con fini politici. In altre parole: un nemico.
La questione, tutto sommato, propone con. Estrema chiarezza l’evoluzione-involuzione del post-fascismo. Non essendo immaginabile una sua riproposizione novecentesca, l’estrema destra mira al bersaglio grosso, restando, formalmente, nell’ambito democratico. Chi riceve il consenso popolare ha il diritto di governare e deve poterlo fare senza lacci e lacciuoli di qualunque natura: politica, economica, giudiziaria. Questo schema, tutto sommato semplice, ottiene una longevità senza limiti, perché i governanti democraticamente eletti possono garantirsi una permanenza senza limiti, adottando ogni strumento utile, ivi compresa l’impunità giudiziaria (Trump ha potuto farsi assolvere di fatto dall’Alta Corte USA che nel primo mandato presidenziale aveva contribuito ad eleggere per due terzi. Al di là del giudizio sulla sentenza di condanna a Marine Le Pen, che vede l’UE parte offesa (sono stati usati indebitamente soldi europei per attività politiche nazionali), la scommessa della destra guidata da Trump e Musk (due milioni di euro donati a elettori di giudici della Corte del Wisconsin, durtante una curiosa cerimonia).
E’ in gioco il principio della democrazia, la divisione dei poteri.
Nel celebre c, Montesquieu enunciava un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: “Perché non si possa abusare del potere bisogna che per disposizione delle cose il potere freni il potere.” Questo monito, che costituisce l’essenza stessa della teoria della separazione dei poteri, continua a risuonare con forza nei sistemi democratici moderni, laddove la tensione tra il potere esecutivo e quello giudiziario si manifesta ciclicamente, assumendo forme più o meno acute.
La recente affermazione di Donald Trump secondo cui il Dipartimento di Giustizia debba mostrare lealtà all’esecutivo, piegandosi alle scelte politiche in virtù di un mandato popolare, riaccende un dibattito cruciale: è legittimo che il potere esecutivo possa indirizzare l’azione giudiziaria? E, soprattutto, quale spazio resta all’indipendenza della magistratura in uno scenario simile?
Spostando lo sguardo all’Italia, il conflitto tra governo e magistratura non è certo un fenomeno recente. Dagli scontri verbali alle riforme giudiziarie proposte con toni spesso polemici, la dialettica tra potere politico e ordine giudiziario si consuma nel perenne tentativo di ridefinire i confini dell’equilibrio istituzionale. Tuttavia, è proprio in questo spazio di tensione che la democrazia trova la sua massima espressione: nessun potere deve potersi ergere sopra gli altri senza controllo.
La separazione dei poteri, infatti, non è un orpello giuridico ma il pilastro che impedisce la deriva autoritaria. In Italia, la Costituzione sancisce chiaramente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (art. 104), tutelandola da ingerenze esterne che potrebbero comprometterne l’imparzialità. Ogni tentativo di subordinare l’azione giudiziaria al potere politico rischia di minare questo delicato equilibrio, aprendo la strada a pericolose derive.
Tuttavia, la questione non è meramente teorica. Il rischio è che il dibattito sul “governo dei giudici” venga strumentalizzato per delegittimare l’operato della magistratura, dipingendola come un potere antagonista al governo eletto dal popolo. Questo approccio alimenta un clima di sfiducia istituzionale, in cui la dialettica tra poteri si trasforma in conflitto aperto, compromettendo l’efficacia del sistema democratico.
È legittimo che il potere esecutivo voglia efficienza e trasparenza nella giustizia, ma tale esigenza non può giustificare pressioni indebite o riforme che intacchino l’autonomia della magistratura. La sfida è semmai quella di migliorare il funzionamento del sistema giudiziario senza sacrificare i principi fondamentali dello Stato di diritto.
L’Italia, come ogni democrazia matura, deve saper resistere alla tentazione di concentrare il potere, ricordando che la vera forza delle istituzioni risiede nella loro capacità di autolimitarsi. Il conflitto tra governo e magistratura, se incanalato nel rispetto delle regole costituzionali, può essere uno strumento di crescita democratica. Se invece degenera in una lotta di potere fine a sé stessa, rischia di erodere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Montesquieu ci ricorda che il potere, lasciato senza freni, tende naturalmente all’abuso. Difendere l’indipendenza della magistratura significa, dunque, difendere la democrazia stessa. In un’epoca in cui il consenso popolare è spesso invocato come legittimazione assoluta di ogni scelta politica, è fondamentale riaffermare che il voto non concede pieni poteri, ma è solo uno degli ingranaggi di un sistema più ampio e complesso.
È proprio la capacità di mantenere questi equilibri a distinguere una democrazia matura da una che rischia di scivolare verso derive autoritarie. E in questa sfida, il potere deve continuare a frenare il potere. Sempre.