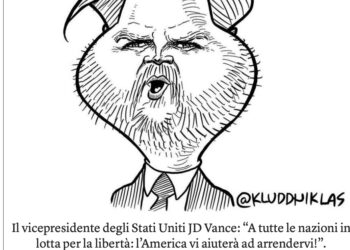Dagli attacchi informatici alle campagne di disinformazione: l’inchiesta su NoName rivela un sistema di influenza ben radicato nel nostro paese. C’è un filo che lega le tastiere di alcuni hacker italiani ai centri di comando della guerra ibrida russa. Non è un filo tecnico, ma ideologico, e ancor più inquietante: è il filo della propaganda, dell’influenza occulta, della destabilizzazione sistematica. Niente di nuovo, è vero. Basti ricordare l’influenza russa sul successo elettorale di Donald Trump nel primo mandato, o sulla Brexit, o ancora sulle campagne eletorali di paesi europei, come la Romania. Nell’operazione coordinata da Europol e annunciata nella sede di Eurojust ha portato all’arresto di alcuni membri del collettivo NoName, gruppo noto per il sabotaggio informatico di infrastrutture critiche in Italia — ministeri, reti finanziarie, snodi logistici — l’aspetto più rilevante dell’indagine è un altro: i sabotatori non erano solo hacker, erano anche attivisti digitali pro-Putin, impegnati in vere e proprie campagne di propaganda sui social e in circuiti chiusi come Telegram (dai quali ci si rifornisce per garantire una circolazione virale nelle pagine FB, Instagram, Tc-toc e nelle chat).
Non si tratta, a quanto emerge dalle carte della Procura della Repubblica di Roma, di professionisti dell’informatica. Nessuna sofisticata competenza era richiesta: le macchine, le istruzioni, persino i target degli attacchi, venivano forniti dai referenti russi. L’obiettivo era doppio: sabotaggio delle infrastrutture e sabotaggio del discorso pubblico. Attraverso meme, post virali, notizie false e contenuti visivamente accattivanti ma tossici, simpatizzanti dichiarati del regime putiniano avrebbero contribuito a diffondere narrazioni favorevoli al Cremlino e denigratorie verso politici, intellettuali, giornalisti e istituzioni che si opponevano apertamente alla guerra russa contro l’Ucraina.
Le attività non sono sporadiche. Vengono condotte con metodo, con una divisione interna dei ruoli, con contatti regolari con soggetti esterni all’Italia. In altre parole, siamo di fronte non a lupi solitari del web, ma a un sistema strutturato che opera all’interno della nostra società, sfruttando le sue fragilità: sfiducia, disinformazione, polarizzazione.
Quanti sono oggi, in Italia, i canali Telegram, i profili X (Twitter), le pagine Instagram che veicolano messaggi filorussi, spesso mimetizzati da “opinioni alternative” o da “controinformazione”? Quante volte, sotto post di cronaca internazionale, si legge una marea di commenti che inneggiano a Putin, denigrano l’Ucraina o accusano l’Occidente di “ipocrisia”? Quanta parte di tutto ciò è spontanea e quanta è frutto di coordinamento?
Se la propaganda è legittima, deve tuttavia preoccuparci quando si trasforma in operazione sistematica, infiltrata e diretta da interessi esterni ostili. La guerra non si combatte solo sul campo. È una guerra di percezioni, e l’informazione — o meglio, la disinformazione — è una delle sue armi più affilate. Il web, in particolare, è diventato il nuovo fronte: una trincea immateriale in cui l’invasione non si vede, ma si sente nei commenti, nei “like”, nelle valanghe coordinate di contenuti orientati, nella manipolazione algoritmica delle emozioni.
Le evidenze di questa inchiesta, se confermate, dimostrano che la Russia non guarda, agisce. E agisce anche da dentro. Non sappiamo quanti siano i simpatizzanti o i mercenari digitali già operativi nel nostro paese. Ma sappiamo che ci sono. E sappiamo che si muovono in reti, con strumenti, obiettivi e (probabilmente) fondi. In altre parole: c’è un sistema. Sbaglia perciò chi pensa che il danno maggiore venga dai virus informatici. Il virus più pericoloso è l’idea — l’idea infettiva, ripetuta, insinuata, resa “plausibile” nel rumore del dibattito. Ed è quell’idea — che l’Occidente sia ipocrita, l’Europa bellicista, l’Ucraina sia corrotta, Putin “uno statista vero” — che sta lentamente infiltrando le menti più vulnerabili. Perché la guerra ibrida passa anche dai meme. E chi li condivide, a volte, per gioco.